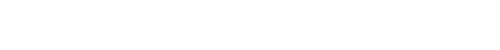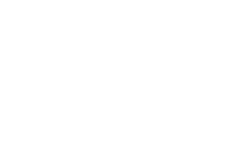Una class action degli autisti di Uber (e Lyft) ha imposto il riconoscimento dello status da dipendenti e non di "contrattisti indipendenti". La multinazionale Usa dovrà riconoscere le tutele fondamentali a questi lavoratori
Quando si parla delle proteste Uber, si pensa a quelle dei tassisti che in Italia, in Belgio, o negli Stati Uniti difendono le loro licenze e scendono in piazza bloccando le città. Il servizio taxi o noleggio di auto con conducente mediante smartphone ha provocato la reazione fuori dalle righe dell’ex ministro dei trasporti Lupi secondo il quale «qualsiasi app che eroghi un servizio pubblico non autorizzato compie un esercizio abusivo della professione». La lotta Uber-tassisti sarebbe «un problema di ordine pubblico». Il 26 marzo la regione Liguria ha praticamente dichiarato illegale il servizio Uber sul suo territorio, modificando la legge regionale sul trasporto pubblico mediante servizi pubblici non di linea. La «sharing economy» proposta Uber ha un valore di 41 miliardi di dollari e non è quotata in borsa. Si propone come una sfida del «libero mercato» contro le corporazioni protette dallo Stato e funziona attraverso la «disintermediazione» tra clienti, Stato e impresa. Il suo obiettivo è sostituire il principio del servizio pubblico nella mobilità penalizzato non solo dalle inefficienze, ma soprattutto dai tagli colossali al Welfare. Due recenti sentenze emesse dalla corte federale di San Francisco hanno aggiunto un elemento al quadro del «capitalismo on demand». Il tribunale ha infatti dato ragione ad una class action degli autisti freelance guidati dal tunisino Ramzi Reguii, fondatore del sindacato auto-organizzato «Drivers Network». Gli autisti non sono «contrattisti indipendenti», ma «dipendenti» e Uber e Lyft devono rimborsargli le spese, incluso il costo della benzina e della manutenzione dei veicoli con i quali lavorano. Fino ad oggi, questi costi sono stati scaricati sulle loro spalle, insieme al pagamento dei contributi per la sicurezza sociale, quello della disoccupazione. La sentenza rivela la presenza di un conflitto radicato negli Stati Uniti tra freelance e aziende e potrebbe cambiare i principi fondatori della «sharing economy» che funziona sulla precarizzazione del lavoro autonomo e precario dei freelance. Il loro guadagno dipende dalla «valutazione» (o «gradimento») dei clienti recuperati sulle app. Se la media è inferiore a 4,7 punti su 5 Uber può «disattivarli». La vittoria del «Drivers Network» è un granello di sabbia in questo gigantesco meccanismo estrattivo. Uber ha annunciato la creazione entro il 2020 di una «sinergia» con Google. Sperimenterà una tecnologia del «Self-driving», cioè un taxi senza autista. Sembra fantascienza, ma questa soluzione potrebbe permettere di risparmiare sul costo della forza-lavoro che rischia nel frattempo di salire. «Elimineremo l’altro tizio nella macchina» ha detto Travis Kalanick, fondatore di Uber, già nel maggio 2014. Il «tizio» è l’autista, s’intende. Questo è lo scenario che prepara chi pensa di essere al di sopra delle leggi. Secondo un’inchiesta della tv all-news francese Bfm la società americana ha creato un dispositivo di «ottimizzazione fiscale» che permette di inviare i cospicui guadagni dalla sede fiscale in Olanda (a cui fanno riferimento le filiali europee) nei «paradisi fiscali» delle Bermude e poi nel Delaware. Dispositivi fiscali simili vengono usati da multinazionali dello sharing come Google e Facebook che fatturano in Irlanda. ***
Leggi l’analisi completa su Lavoro Culturale *** Doppia mossa di Uber: boicotta lo sciopero dei trasporti e diventa partner di Expo


















 Clickmobility:
Clickmobility: