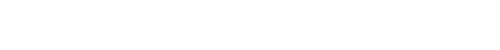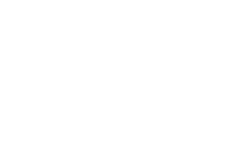I gabbiotti dei capolinea davanti alla stazione Termini sono il precipitato dello sfascio. In uno di questi cubi di vetro e alluminio di tre metri per tre un meccanico discute animatamente con quattro-cinque colleghi. Provo a entrare e un anziano mi fulmina: «Te pare er momento de fa’ domande?». Riprovo due banchine più in là in un gabbiotto meno congestionato nonostante l’aria condizionata drammaticamente fuori uso. Il capo-turno, quello che con un mozzicone di matita segna chi prende servizio e quando su due delle linee più trafficate per il centro, è un ciociaro ben piantato con una ricetta semplice quanto irrealistica: «Mille autisti in più e cinquecento mezzi nuovi». Peccato che stia parlando di un’azienda sul baratro, che in dieci anni ha perso quasi 1,6 miliardi di euro, più di Alitalia quando ancora era il golden standard delle dilapidatrici di soldi pubblici
"In maniera bipartisan, ancorché con picchi spaventosi sotto l’amministrazione Alemanno, la municipalizzata dei trasporti romani Atac è diventata una specie di microcosmo di tutto quello che non va nel Paese. Politica clientelare. Manager irresponsabili. Dipendenti impuniti." Questa l'opinione espressa da Riccardo Staglianò nell'articolo ospitato dal Venerdì di Repubblica del 14 agosto, che riportiamo. La colpa è sempre di qualcun altro. Della Regione con arretrati totali pari a un miliardo duecento milioni di euro di trasferimenti. Dei ricambi che mancano. Dei «70 dirigenti = 1.000 autisti», tormentone suggestivo ma circa tre volte sovrastimato, che ritornerà spesso. Hanno tutti un piccolo pezzo di ragione, ma questi piccoli pezzi, insieme, producono un torto colossale. Di fronte al peggioramento del servizio a luglio, per lo sciopero bianco che gli autisti negano, ma senza il quale si faticherebbe a giustificare un’impennata del 300 per cento di vetture giudicate inidonee rispetto al luglio scorso, il sindaco Marino ha fatto la voce grossa: «Azzererò il Cda e cercheremo un partner privato». Nemmeno un emiro ubriaco comprerebbe un’azienda in queste condizioni, ha ironizzato a distanza l’ex sindaco Rutelli. Gli esperti gli danno ragione. Fosse un’impresa privata l’Atac sarebbe morta da tempo. Ma come e perché è arrivata al coma farmacologico in cui versa da anni? La vicenda è fastidiosamente complessa. Una ventina di anni fa la situazione era simile a oggi: 1.400 miliardi di lire di perdite ripianate dal pubblico. La tentazione era di chiudere, ma la giunta Rutelli, da poco insediata, non se la sentì. I contributi comu- nali passarono da 900 a 400 miliardi, partì un piano da 5.000 esuberi (quasi un terzo del totale), aumen- tarono le tarife: una cura da cavallo che in due-tre anni portò dei risultati. Per renderli irreversibili l’assessore ai trasporti Walter Tocci decise nel ‘99 di dividere l’azienda in due: la parte di regolazione (che tipo di servizio doveva essere assicurato) restava pubblica, quella industriale (guida, etc) veniva affidata a due società pubbliche (Trambus e Met.Ro.) che avrebbero dovuto lasciare il posto ai privati. Fu allora che, per le linee periferiche, ovvero circa un quinto del totale, vinse la Tevere Tpl (oggi Roma Tpl). I prezzi del servizio per chilometro, spiega Tocci, oggi senatore del Pd, erano circa la metà di quelli di Atac. Doveva essere solo l’inizio di un meccanismo concorrenziale. Ma nell’ultima parte del suo mandato il sindaco Veltroni introdusse l’in house, malignamente tradotto «casereccio» dai detrattori, una nuova forma di affidamento diretto a società pubbliche di proprietà dello stesso ente che affida. Con gli anni, invece di far scendere i prezzi pubblici verso il livello dei privati, fa salire questi ultimi, che si avvicinano al livello dei primi. Il che però non smentisce la bontà del metodo che Tocci rivendica anche oggi: la privatizzazione tout court è una stupidaggine. Prima bisogna garantire che il pallino resti in mano pubblica, poi dividere il servizio tra una decina di fornitori scelti con una gara. A quel punto i prezzi scenderanno e il Comune non sarà ricattabile da monopolisti di fatto. Una volta modificata la cornice, resta una miriade di problemi pratici. Uno che sa immaginarli bene è Simone Gragnani, manager della società di consulenza Lem Reply e grande esperto di mobilità urbana, molto ascoltato sino all’arrivo di Alemanno, che si farà ricordare per i circa 800 assunti nelle file amministrative e per la moltiplicazione di dirigenti (un’ottantina contro la trentina della milanese Atm) passata alle cronache come Parentopoli. «Biglietti e abbonamenti, in un confronto europeo, costano troppo poco. Per coprire tratte distanti come le nostre la quota annuale potrebbe costare cinque volte gli attuali 250 euro». Roma considera, per motivi di sensibilità politica, come urbane tratte che altrove sarebbero senz’altro extra-urbane. «Se proprio nessuno se la sente di cambiare, si potrebbe alzare il prezzo per tutti e poi, come a Monaco, fare sconti a chi fa solo poche fermate». Per non dire dello scandaloso tasso di evasione del biglietto. Per Gragnani il 30 per cento che gira è forse esagerato, ma in periferia gli stessi autisti giurano che potrebbe essere ben oltre il doppio. L’azien- da, interpellata, si è limitata a par- torire una rispostina scritta. Il motivo per cui Roma, a diferenza di Parigi, Londra o New York, non può far entrare i passeggeri solo dalla porta anteriore verificando che abbiano un titolo di viaggio sa- rebbe perché «da noi due dei circa tre milioni di spostamenti al giorno avvengono via bus. Un volume importante di passeggeri non gestibili con la modalità di controllo indicata, in particolare nelle ore di picco». Peccato che a New York, dove i passeggeri sono anche un po’ di più, questo avvenga senza problemi (gli autisti addirittura si alzano per aiutare a salire i disabili), come succede a Parigi (3,6 milioni: lo slogan è «monto e convalido») o a Londra, dove i viaggiatori quo- tidiani sono ben sei milioni, tre volte i romani. Basterebbe spingersi fino a Bologna per vedere all’opera il formi- dabile multitasking di guidare e vendere allo stesso tempo. E allora, di che parliamo? Restano, malinconici, i numeri: su 900 milioni in- cassati all’anno a Roma meno del 30 per cento (240 milioni) viene dai biglietti, contro il 45 per cento di Milano. Se si recuperasse l’intera diferenza sarebbero 120 milioni in più, che arriverebbero qua- si a ripianare i 150 milioni di buco annuale. L’altra grossa voragine è quella dei trasferimenti dalle Regioni. Quando intorno al 2008 la governatrice del Lazio Renata Polverini tagliò drasticamente i fondi per l’Atac, il sindaco Alemanno non sembrò prendersela troppo. Se domani la nominassero plenipotenziario, chiedo a Gragnani, cosa farebbe? «Metterei intorno a un tavolo tutti: Governo, Regione e Comune, per le risorse; l’azienda, per tarife e maggiore efficienza, e i sindacati per la produttività. Solo così potremmo risolvere questa vicenda». Forse. Pochi giorni dopo 2-300 autisti Atac si danno appuntamento per un sit-in davanti al Campidoglio. Solo il combattivo consigliere democratico Athos De Luca afronta l’arena. Gli parano davanti Maria, una disabile che ha grossi problemi sulla linea Roma-Lido perché le pedane sono poche e deve aspettare un’eternità. L’unico politico applaudito è Marcello De Vito, capogruppo romano M5S, cui, al colmo dell’entusiasmo, fanno indossare un camicia azzurra Atac. Parrebbe che i francesi di Ratp, che in passato ha già fatto una proposta per rilevare la Roma-Lido, hanno ormai un ufficio stabile a Roma. Osservano. Pronti a farsi avanti, al più tardi nel 2019 («Qualcuno ha interesse a mettere in stato comatoso l’azienda per poi venderla. E intascare una super-mazzetta», sostrerrebbe un dirigente che rimane anonimo nel pezzo di Staglianò). Per Andrea Boitani, economista della Cattolica che ha guidato un comitato tecnico di controllo sull’Atac, non c’è ormai altra strada che il fallimento: «Va tolta al Comune, perché le pressioni clientelari sono forti. Ci sono troppi dipendenti inattivi. Non si possono lasciare sul lastrico, ma si deve vigilare perché non godano degli assurdi privilegi che abbiamo consentito per i dipendenti Alitalia. Magari servirà fare un bad company per liquidare il patrimonio e vendere il resto. Serve un commissario, e anche piuttosto bravo». Se c’è uno che non la potrebbe vedere più diversamente è Alessandro Capitani, il segretario Filt-Cgil del Lazio: «Il servizio deve restare pubblico. Anzi, si dovrebbe fare un’azienda unica regionale per centralizzare la gestione e ridurre i costi». Una prospettiva carrozzonesca che fa venire i brividi alla maggior parte degli esperti contattati. Intanto arriveranno 27 milioni di euro dal Comune, per passare l’estate in attesa dei 300 previsti a ottobre dalla Regione. Iniezioni robuste e occasionali che fin qui non hanno fermato il crollo. Non sarà la contromisura più redditizia, ma un’idea comparativa la dà: le sanzioni contro chi non paga il biglietto a Milano rendono 8 milioni di euro all’anno, a Roma 1,7. Il fatto che ci sia solo una settantina di controllori su un organico di quasi 12 mila persone è parte della spiegazione. E sintomo di un’incapacità gestionale, profonda, calcificata, inescusabile.



















 Clickmobility:
Clickmobility: